Popolo di santi, poeti, navigatori e, da oggi, anche di videogiocatori. Negli ultimi giorni, rovistando tra i rumor di Jeff Grubb, i cosplay di 2B al limite del soft-porn e le live nelle piscinette, un comunicato in particolare è rimbalzato da testata in testata: Lo Stato italiano riconosce i videogiochi come forma d’arte.
Come un Di Maio videoludico, ci siamo tutti affacciati ai balconi virtuali delle nostre testate proclamando la vittoria, la sconfitta dell’ignoranza guardando ad un futuro migliore, migliore di Calenda che va su Twitch con il faina. Oggi sperimentiamo una formula meno analitica, lasciando spazio alle mirabolanti considerazioni di uno che in fondo ama i videogiochi anche se spesso non si vede. Ma quindi oggi, da giocatore, posso considerarmi un uomo di cultura?
Di opinioni ne ho sentite davvero tante, ho riflettuto ed insieme ai miei colleghi abbiamo soppesato le diverse implicazioni economiche e sociali, abbiamo discusso a lungo su cosa fosse giusto e cosa sbagliato. Ma ogni spunto, ogni discussione e ragionamento portavano sempre e solo alla stessa domanda:
“Se il videogioco come abbiamo imparato a conoscerlo è arte, e già su questo potremmo aprire un’altra discussione, il videogioco in italia si può considerare allo stesso livello?”
Prima di giungere a questo interrogativo bisogna necessariamente fare un passo indietro e tornare al momento in cui il ministro Franceschini riconosce il videogioco come forma d’arte e lo inserisce all’interno di quelli che possono essere considerati “beni culturali”. Un riconoscimento è davvero nulla senza le sue opportune conseguenze e, da giocatore e redattore, non ho mai sentito il bisogno di essere riconosciuto come qualcosa di diverso da un “fancazzista”, non è mai stato importante.
Non è che il ragazzino che passa le giornate su Warzone oggi potrà dire alla mamma “hey, sto facendo un’attività culturale, deal with it”.

Abbiamo avuto la nostra coccarda da parte dello stato che, con i suoi 30 anni di canonico ritardo, si è svegliato, ha realizzato che il millenium bug è ormai roba vecchia ed è inciampato in Metal Gear Solid 3.
A questo punto direi anche: Buongiorno.
Certo, resta l’ironia di un paese che, nel 2021 riconosce l’estro artistico del videogioco ma fatica a stare al passo con l’inclusività di genere ma questi sono davvero altri discorsi, come sempre vale la regola del “Noi parliamo soltanto di videogiochi”.
Tornando ai nostri amati videogames, va detto che lo stato ha fatto un piccolissimo passo avanti per spingere il settore dello sviluppo in Italia, proponendo un Tax Credit mirato ad alleggerire quei coraggiosi sviluppatori nostrani che si dilettano nell’arte del giuoco elettronico.
Cercando di scacciare l’immagine dello sviluppatore di Daymare 1998 che lancia un mouse contro il monitor urlando “perché non parti!” come un novello Michelangelo, la riflessione si sposta su due fronti ben distinti:
Quali sono quegli studi di sviluppo che potranno usufruire del tax credit?
Ma sopratutto, che cos’è il Tax Credit, o credito d’imposta?
In parole semplicissime, una riduzione delle tasse pagate da un’azienda nell’esecuzione della sua attività, che viene erogato sotto forma di rimborso una volta pagate le tasse, oppure come sconto vero e proprio. Non si tratta quindi di un finanziamento, cioè soldi che vengono consegnati alle aziende sotto forma di prestiti o di regalo (i cosiddetti finanziamenti “ a fondo perduto”). Se paghi delle tasse quindi, ti vengono scontate. Fine. Per poter accedere a questo “regalo” dello stato, gli studi di sviluppo però devono rispettare dei requisiti. Quello più impegnativo è il fatto di avere un capitale sociale di 10.000 €, cioè costituire una Società di Capitali, come una SRL (Società a Responsabilità Limitata).
Questo fa già capire che gli studi di sviluppo con questa caratteristica in Italia sono davvero pochissimi. Per i piccoli studi, per chi sviluppa lontano dai meccanismi delle società o in totale indipendenza senza costituire un’impresa (con tutti gli obblighi fiscali e di diritto che questa comporta), non ci sarà possibilità di accedere al Tax Credit. Il credito d’imposta è calcolato poi sulla base dei costi di sviluppo del videogioco, e può raggiungere fino al massimo del 25% del valore dei costi dichiarati di produzione, fino ad un massimo di 1 Milione di Euro. Ma vogliamo ricordare che siamo in un paese in cui solo una ridottisma percentuale di aziende di sviluppo supera i 2 milioni di € di fatturato.
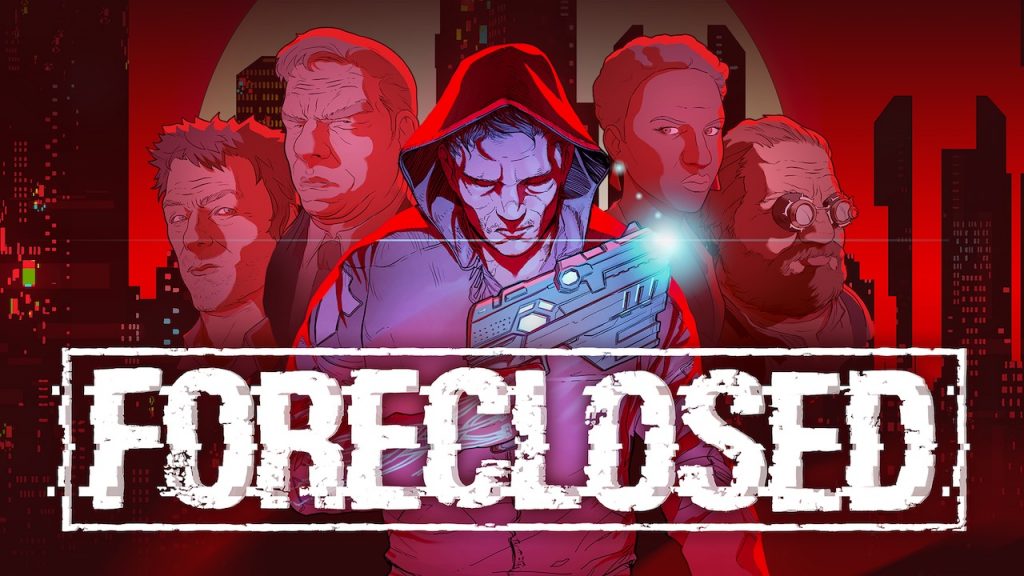
Da un punto di vista aziendale, soprattutto in Italia, un tax credit è un ottimo incentivo alle società sia per fare investimenti sul personale o in ricerca e sviluppo, sia per dichiarare la maggior parte delle spese sostenute. In questo modo si può favorire una crescita di più aziende che porta conseguentemente alla crescita dell’intero settore. Se le aziende più grandi iniziano ad investire seriamente nelle figure professionali, ed esiste un settore nostrano di professionisti che vengono formati all’interno di società già avviate, vedrete che inizieranno a spuntare altre società simili, perchè a quel punto conviene. In questo modo si inizia a far crescere un settore.
Tuttavia, è giusto lasciare allo sbaraglio tantissime altre realtà che non possono accollarsi il rischio d’impresa per i più svariati motivi, ma hanno comunque talento e idee da vendere? Ovviamente no. Il tax credit non è uno strumento che può permettere ai piccoli studi di proliferare, cosa che invece potrebbero fare i finanziamenti a fondo perduto. La situazione è estremamente complessa e piena di aree grigie, ma proprio per questo ha bisogno di molta più regolamentazione, proprio per permettere una crescita proporzionale del settore. E’ giusto favorire dal punto di vista fiscale le aziende che contribuiscono in maniera più consistente alle finanze dello stato, ma bisogna anche supportare quelle che stanno sbocciando, perchè saranno i contribuenti di domani.
Il mercato dello sviluppo di videogiochi italiano è debole e povero: necessita di una legiferazione “ad hoc” e soprattutto necessita di volontà nell’investire con un po’ di rischio. E’ facile cacciare i soldi in mano a chi ha già un’azienda florida o comunque stabile, ma così il mercato al massimo lo tieni fermo dov’è: per cambiare, un mercato si deve ESPANDERE e per espandersi ha bisogno di iniezioni di risorse che solo uno Stato proiettato verso il futuro si prende la briga di avviare.
Quindi quale sarebbe il risultato? Il grande videogioco-cultura agevola chi già i videogiochi li fa da tempo, lasciando nello sconforto più totale coloro che si avvicinano timidamente a questo mondo. Ricordiamo che il percorso per lavorare in questa industria dal punto di vista creativo è paragonabile a quello dell’università della vita.

E’ un piccolo passo senza dubbio, un altro step insieme al First Playable Fund (ancora in alto mare come dicevamo) che però viene spacciato per grande rivoluzione. Personalmente non ho nulla in contrario a questi tentativi di ottenere qualcosa dallo Stato italiano sul fronte della produzione di videogiochi, ma se ci mettiamo ad applaudire ogni volta che ci viene lanciata una nocciolina mezza scaduta NON stiamo facendo nulla di buono per il nostro settore.
Quindi è veramente questo quello che serve per far crescere l’industria?
Se da un lato lo Stato italiano riconosce il videogioco come forma d’arte, nei fatti va a supportare il settore come se non appartenesse ad una categoria così “volatile”. È ovvio che il tax credit non aiuterà lo sviluppo, non ci porterà sugli schermi dei giocatori di tutto il mondo, non farà nulla di tutto questo. E allora cosa serve?
Serve saper fare i videogiochi.
Gli Italiani si sono sempre avvicinati alle forme d’arte con l’arroganza tipica di chi primeggia in ogni campo. D’altronde l’Italia è patria dei massimi esponenti di ogni forma d’arte, da Michelangelo a Dante, Giuseppe Tornatore e Vittorio Gasman, la lista è veramente lunga. Purtroppo, per quanto ci piaccia esaltarci quando un team italiano pubblica un titolo, il videogioco italiano non è neanche lontanamente paragonabile né in forma né in intenti a quanto siamo abituati a vedere all’estero. Pensateci, il videogioco potrebbe essere la prima forma d’arte dove gli italiani non sono poi così bravi.

Il mercato dei videogiochi prodotti in Italia (a differenza del mercato consumer, chi i giochi li compra e li usa per intenderci) era di dimensioni irrisorie 10 anni fa. E (sorpresa delle sorprese) nonostante un innegabile incremento nel tempo, resta irrisorio tutt’ora generando un giro d’affari, un giro di assunzioni e di tasse incamerate dallo Stato decisamente irrilevante. Questo scenario sconfortante non lo racconto io, ma lo raccontano tutti gli indicatori che vengono annualmente condivisi e che mostrano una stagnazione (soprattutto in termini di soldi che girano nel settore) imbarazzante. Stagnazione che viene spacciata per “consolidamento” dai soliti trombettieri impegnati nel divulgare messaggi ottimistici, atti principalmente a flettere i muscoli dove ci sarebbe solo da chinare il capo e lavorare in silenzio.
Francia, Inghilterra, Svezia, Polonia ed altre nazioni europee hanno già intrapreso questo percorso tempo fa, e non si limitano ai casi più eclatanti quali UbiSoft, CD Projeckt Red o gli altri giganti del Vecchio Continente. Parliamo anche di altre realtà medio-grandi rimaste nel cuore dei videogiocatori di tutto il mondo, come Ninja Theory in UK, Quantic Dream e Dontnod Entertainment in Francia, Crytek e Daedalic Entertainment in Germania, per non parlare della mole di studi con sede sul suolo svedese, da DICE a Hazelight Studios passando per Mojang, gli autori di Minecraft. Tavolta è proprio da un budget risicato che nascono alcune vere e proprie perle di successo, come nel caso dello stesso Minecraft ma anche di altri titoli a caratura indie come Hollow Knight e Fez, capaci di registrare vendite da record nati da piccoli studio come Team Cherry e Polytron. Senza nulla togliere agli ottimi studi presenti sul nostro territorio, manca una vera e propria eccellenza che si sia distinta a livello globale portando un contributo indelebile nel panorama del videogioco moderno, una stella nel firmamento digitale che possa rappresentare la nostra nazione in ambito videogames. Stanchi di essere videoludicamente rappresentati soltanto attraverso le più disparate parodie, e non c’è nemmeno bisogno di scrivere a quale idraulico baffuto mi stia riferendo, è tempo di dimostrare con i fatti che anche l’Italia e gli italiani sanno fare videogiochi. Ci vuole un’idea coraggiosa, un colpo di genio, un lampo nelle notte che possa rischiarare il profondo buio artistico nel quale ci troviamo da ormai troppo tempo. Forse un giorno, in mezzo a tanti santi, poeti e navigatori, potremo finalmente mandare un nostro astronauta armato di development kit e motori grafici a piazzare la bandiera tricolore su quel pianeta vasto e tutt’ora sconosciuto che è il mondo dei videogiochi.
